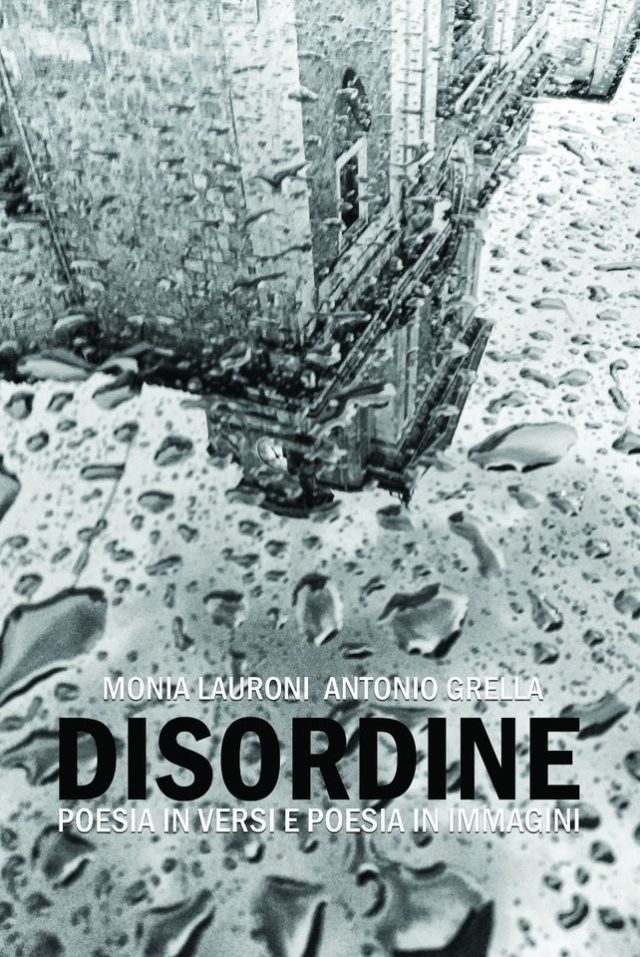C’è un dono disvelato nel Disordine di Monia Lauroni, ed è dono fertile: la assoluta e meravigliosa indifferenza dell’autrice verso l’appagamento. Come quello di un’amante riluttante a comporsi e ad abbandonare il talamo dopo un orgasmo condannato dalla temporalità a liquefarsi nella stanca indifferenza di un dopo. In prosa il trait d’union fra escatologia laica e narrazione è quasi sempre un ingombrante fardello da cui prescindere è difficile, in certe forme di poesia esso si palesa in maniera più subdola, prendendo polpa in totem canonici come la speranza, la morte, il senso stesso della lotta, perfino il destino in abuso perenne di utilizzo, scenico e concettuale. Con Monia Lauroni la mission si sostanzia nella misura in cui mission non c’è. Il fine didattico scompare. E con esso vanno a patibolo ogni pastoia, ogni diga emozionale che a ben vedere frena e sempre frenerà la sontuosità dei pensieri. E’ come se nelle poesie della Lauroni l’assenza di un fine e di una nicchia di collocazione in canone fosse grimaldello per l’infinito. E’ un mondo tetro e luminosissimo, manicheo perché fatto di sensazioni. Sono guizzi d’occhi e d’anima talmente intensi e ben incasellati nel lessico da risultare giganteschi camei a sé stanti del male di vivere. E di quanto questo male sia esorcizzabile con la vaghezza del suo essere, con un fumus benevolo che non è approssimazione, ma scelta consapevole di offrire brividi, non spunti. Perché nella Lauroni il male è la piccineria di un’umanità che non ha gli occhiali giusti, che ha perso di vista il bello, che tartufa il mediocre e grufola nell’immanente. Tuttavia non si sa mai con certezza se questo ammanco universale sia deprecabile fine o meraviglioso mezzo. Perso nell’impegno benevolo di sciogliere questo dubbio, il lettore ha una sola possibilità: quella di immergersi nei versi di questa silloge e scoprire tutti i piani possibili di lettura del mondo. Quelli del disincanto, quelli dei colori usati per dare anima alle parole, di animali e piante che si fanno elfici e norreni non per mostruosità, ma per esatta collocazione emozionale. E poi quelli dell’urbanistica che fissa il momento e delle chiese che sono orpello alla curiosità di scrutare la fede con gli occhi inaspriti dal limone della delusione. La Lauroni è maestra di sensazioni e parole, è un fatto, e riesce a tradurne i moti scavalcando a pie’ pari la finestra di Overton. E conducendo un lettore mai intimidito ma di certo ingolosito nella lettura verso canoni esagerati ed eccezionali. Eppure c’è qualcosa, nelle poesie di Monia Lauroni, che mette in coda perfino l’idea del bel cimento con versi sontuosi: è la melanconia di ritorno verso la sua Veroli. Una città che lei proprio non riesce a non amare ma che ama con la contezza universale di chi ne conosce le zoppie prima che gli ingegni. E che di entrambi ha patito la mannaia di rimbalzo. Una città che descrive con la minuziosità di una sacerdotessa severa e bambina, truce e campestre, cattiva e redenta da un microcosmo in cui la domanda resta, ma la ricerca vana della risposta basta da sé a voltar pagina. Per continuare la musica senza incarognirsi sullo spartito.
Giampiero Casoni